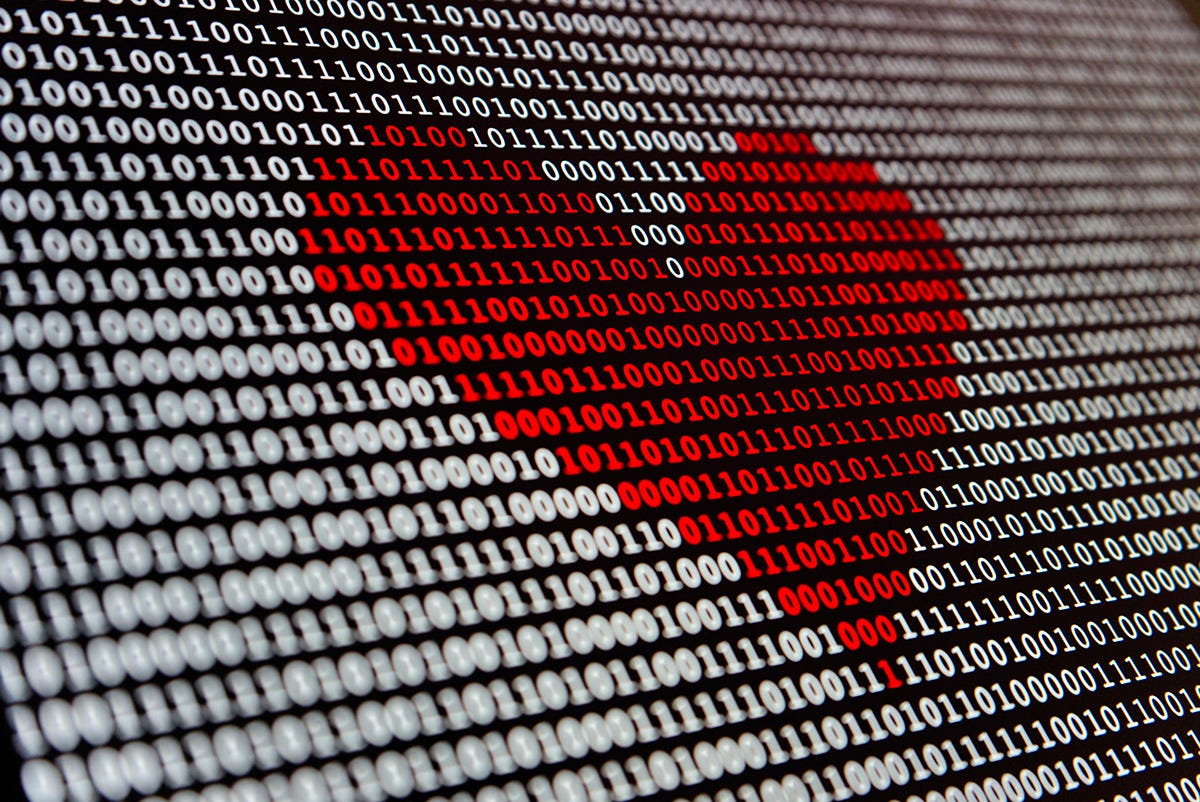Il digitale è colpevole (anche, non solo) anche dei film troppo lunghi a Cannes?
Il digitale torna ad essere additato come la colpa e il male di tutto il male di questo periodo. Non è che la vera colpa sia la leggerezza con cui trattiamo e viviamo quello che sta attorno a noi?
Photo by Alexander Sinn on Unsplash
Su Repubblica, qualche giorno fa, è uscito un articolo che parlava del Festival di Cannes dal titolo “Cannes 2022, in attesa del verdetto, film troppo lunghi: colpa delle serie e del digitale”. Scritto da Alberto Crespi, vi si segnalava:
In generale, cosa ha detto la prima vera Cannes post-pandemia sullo stato di salute del cinema? Semplice: che il cinema non sta bene. Molti film sono lunghissimi, frammentari, sbrodolati. I motivi principali sono due: la moda della serialità, che spinge a dilatare le narrazioni, e la scomparsa della pellicola. Che c'entra la pellicola, direte voi? L'immagine digitale è sempre un'immagine, no? No. Con il digitale, molti registi girano ore e ore di materiale, visto che il costo della pellicola non è più una voce del budget. Sono ormai merce rara il dono della sintesi, la capacità di focalizzare i film su ciò che è davvero cruciale.
Con tutto il rispetto per il giornalista e critico di cinema, che ha il diritto di dire, pensare e scrivere quello che reputa giusto, personalmente mi domando se si sta ancora una volta (e di nuovo) alimentando un tentativo di accollare al digitale tutte le colpe del mondo, più che altro perché è una storia che abbiamo vissuto sin dalla metà degli anni ‘90 e per un po’ sembrava un discorso superato. E invece no, evidentemente l’accelerazione che abbiamo più volte segnalato in questo spazio ha avuto punti fermi quali il periodo pandemico, la fuga da una realtà causata da una guerra in Europa e che ci sconvolge, l’aumento dei costi delle materie prime che stanno modificando in modo evidente alcune evoluzioni che sembravano potersi avvicinare in modo più lento e graduale (per esempio l’aumento folle della carta e dell’energia stanno dando delle spinte nette al mondo già affaticato di giornali e riviste cartacee e, in generale, della comunicazione stampata), ma anche il tanto dialogare di futuri aumentati, virtuali, metaversi, economie decentralizzate, ma addirittura del come il digitale può entrare nelle stanze più profonde ed intime del nostro essere umani (un esempio interessante riguarda lo studio e l’analisi dei dati relativi al sonno, se volete ne parla qui Steven Levy su Wired).
Nella valutazione sulla “lunghezza” dei film a Cannes 2022, cosa c’entra il digitale? Spieghiamo i nostri dubbi in merito, senza che questa voglia apparire una realtà assoluta, ma solo delle opinioni personali:
I film si riprendono in digitale da almeno 15 anni; certo, ci sono state eccezioni, e l’introduzione di questa tecnologia è stata graduale, ma non possiamo certo dire che sia questione nuova. Se i film a Cannes 2022, o negli ultimi anni, si sono allungati (sempre che sia vero, se lo dicono gli esperti sarà di sicuro così), non è certo colpa di una “novità di produzione digitale). Ricordo un convegno a durante il festival di Venezia, dove siamo intervenuti con uno speech, ed era forse attorno al 2005 o giù di li, dove si parlava proprio di questo fenomeno.
Il costo di produzione di un film, anche se ha annullato il budget della pellicola, è cresciuto tantissimo nella sua fase di post produzione (che, giust’appunto digitale) e quindi più è lungo il film, più costa di produzione. Dobbiamo forse smettere di pensare sempre al digitale come alla chiave per azzerare i costi “analogici” (visto che portano spesso a dei costi digitali che a volte sono addirittura superiori), così come non possiamo pensare che il digitale (così come “l’elettrico”) possa azzerare le problematiche ecologiche: i server, i computer, le connessioni, la computazione generano anch’essi volumi elevati di inquinamento. Smettiamola di declamare frasi ad effetto, l’evoluzione “pulita” non passa da un minor consumo di energia, ma da una migliore gestione di questa energia, e ovviamente da una produzione più “pulita” dell’energia stessa.
Forse il modo per far “sopravvivere” il cinema, inteso come spazio dove andare a vedere un film, richiede esperienze che possano avere un “valore percepito” da parte del pubblico. E forse proprio questa dilatazione della narrazione che giustamente viene citata (ma che sembra meno “primaria” nel discorso dell’articolo, più facile mettere in luce l’andare controcorrente, perché certamente fa più presa sul pubblico) è una chiave: le persone che vogliono vedere un film vogliono immergersi, vivere un’esperienza che possa non essere “passeggera”, vogliono entrare in un mondo alternativo e rimanerci per parecchio. Proprio come le serie tv che offrono questo tipo di immersione da binge watching che ha portato tanto successo alle piattaforme di streaming. E, comunque, non è neanche questa una storia nuova. Una volta, personalmente, amavo comprare libri lunghissimi (spessi…) perché pensavo: costnoa come un libro con meno pagine, ma offrono molto di più. In una pizzeria/gastronomina che proponeva la pizza al metro vicino a casa, tantissimi anni fa, dove il trancio costava mille lire, il titolare, quando vedeva ragazzini come me che all’epoca arrivavano con le loro mille lire, chiedeva bonario:
ma vuoi una fetta da mille lire normale o… da mille lire abbondante?
E noi ragazzini all’inizio non capivamo, ma il sorriso del pizzaiolo ci incoraggiava a rispondere...
“Mille lire… abbondante!”
E ci veniva tagliata una “fettona” ben più grande di quella standard, allo stesso prezzo di mille lire. Era chiaro il concetto: costa uguale, ma è già grande, e quindi una gioia in più.
Lo stesso tono che punta il dito contro il digitale che sta “uccidendo i negozi di fotografia” lo troviamo su un articolo del Corriere uscito ieri, dal titolo: “La crisi dei negozi di fotografia”: “Nessuno stampa più, il digitale ci spazza via” firmato da Alessandro Trocino. Altro titolo che attacca e accusa il digitale, quando poi nell’articolo, facendo parlare i negozianti (traducendo concetti legati agli apparecchi fotografi e alle loro evoluzioni un po’ in modo grezzo, ma quando l’informazione diventa generalistica le sfumature si perdono, non fa niente), viene fuori che il problema è che le persone non stampano più, e che per poter ricordare i momenti della vita bisogna stampare. Ma cosa è stato fatto - escluse le eccezioni che confermano la regola - per creare questa cultura? Una chiusura, una mancata voglia di comprendere le evoluzioni, di comprendere la cultura dell’immagine, la creazione di offerte concrete comunicate con il corretto linguaggio alle nuove generazioni (che nel frattempo sono invecchiate di 20 anni quindi ormai abbracciano non solo i giovanissimi, ma anche persone attempate).
Non è il digitale che ha “ucciso” i negozi, sono i negozi che non sono riusciti, non si sono adattati e non sono stati spinti a proporre quello che era ed è la forza di un incontro fisico, modificando magari persino l’architettura dei negozi per trasformarli in luoghi di incontro e di dialogo, di crescita e di interazione. Sì, lo sappiamo, è difficile, ma chi lo ha fatto ha trovato il modo di rimanere in piedi e di trovare un proprio spazio. E nemmeno sono stati usati correttamente, in tutti questi anni, gli strumenti digitali per rafforzare e far crescere le relazioni: i siti sono vecchi, i servizi troppo poco accattivanti, il linguaggio poco efficace.
Nella musica ci sono negozi che vendono solo vinili, le code dei negozi vintage sono sempre lunghissime, i negozi che vendono usato sono super ricercati, la fotografia è nella vita di tutti, il problema è che quello che è passato è quello che “ci piaceva”, e l’evoluzione è stata incredibile e positiva. Ce ne accorgiamo quando usiamo il digitale per tutto quello che è “il resto della vita”, ma ci sembra negativa quando coinvolge qualche parte della nostra vita che non siamo riusciti a trasformare in opportunità.
Smettiamo di dare colpa al “digitale”, perché non c’è nulla che non sia stato influenzato e condizionato dal digitale. Anche le eccezioni, anche le nicchie che del digitale fanno a meno e anzi lo combattono, devono tutto al digitale, per poter esistere. Ci sono “cose” e “non-cose”, come scritto in un recente libro, che vi consigliamo (e che stiamo leggendo e che è citato anche in quell’articolo del Corriere, ma che ho ritrovato anche in altri articoli e segnalazioni, perché è abbastanza “chiacchierato” in questo periodo): ”Le non cose: Come abbiamo smesso di vivere il reale” del filosofo coreano Byung-chul Han che introduce il suo pensiero con questa frase:
«Non abitiamo piú la terra e il cielo, bensí Google Earth e il Cloud. Il mondo si fa sempre piú inafferrabile, nuvoloso e spettrale». Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario tornare a rivolgere lo sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane. Le sole capaci di starci a cuore e stabilizzare la vita umana.
Sì, sappiamo che questa frase genererà consensi, ma l’impressione è che non dobbiamo lottare per tornare alle “cose concrete”, ma rendere concreto tutto quello che facciamo. Quindi anche quando siamo nel “mondo digitale”, quando abbiamo a che fare con “cose-non-cose-digitali”, dobbiamo dare a tutto lo stesso valore, la stessa intensità. Non è una lotta tra titani, tra reale e virtuale. Avremo una vita sempre più legata a beni ed emozioni digitali, il problema è che non diamo abbastanza umanità, senso e valore a quello che diciamo e viviamo perché pensiamo che il digitale sia semplice, sempre disponibile, accessibile, pulito e a costo zero, che si possa usare e buttare, non conservare, non proteggere… e quindi ci circondiamo di qualcosa di inutile. Non so come va a finire il libro in questione (ve lo dirò, o leggetelo anche voi), ma non auspico per me, per le persone a me care e per tutti voi di tornare semplicemente ed esclusivamente verso le “Cose-Cose”, bensì di imparare a rendere COSE tutto quello quello che abbiamo, poco importa che siano o meno della sfera reale o virtuale. Il futuro ci farebbe impazzire nel determinare cosa sia effettivamente “vero” e cosa sia “nulla”, nella nostra testa quello che deve rimanere non sono le cose, ma il valore che diamo a tutto.
I JUMPERlinks per approfondire questi argomenti
Ci siamo accorti che spesso i link inseriti nel testo vengono poco utilizzati dai lettori, ma in ogni caso è comodo comunque avere le fonti che vengono citate nei nostri articoli, visto che non tutte vengono citate al loro interno. Vi forniamo questo elenco qui di seguito, vi sarà più facile recuperarli, nel caso possano servirvi, ora o in futuro.